
Lorenzo Geri
Lorenzo Geri è professore associato di Letteratura italiana presso la Sapienza Università di Roma ed è condirettore del Centro di ricerca scientifica «Laboratorio Erasmo» e del «Centro di Studi sulla Poesia Medievale»
Si occupa di diversi aspetti dell'opera di Francesco Petrarca, dell'evoluzione della poesia lirica in Italia dalle Origini al Cinquecento e dei generi della letteratura barocca (le epistole eroiche, la favola pastorale e il poema epico). Un altro versante della sua ricerca è dedicato alla fortuna di Luciano nel Quattrocento e ai rapporti tra l’Umanesimo italiano e l'Umanesimo del Nord Europa, con una particolare attenzione al ruolo di Erasmo da Rotterdam.
Lorenzo Geri teaches Italian Literature at Sapienza University. His research interests include Petrarca, Boccaccio, Alberti, Pontano, Marino and Italian Theatre Literature of XVI and XVII century. His current research is devoted to the codification of lyric poetry in Italy from the Middle Ages to Renaissance; Petrarch and religious culture; Petrarch and Italian Courts.
Address: Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali - Università di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, Roma 00185
lorenzo.geri@uniroma1.it
Si occupa di diversi aspetti dell'opera di Francesco Petrarca, dell'evoluzione della poesia lirica in Italia dalle Origini al Cinquecento e dei generi della letteratura barocca (le epistole eroiche, la favola pastorale e il poema epico). Un altro versante della sua ricerca è dedicato alla fortuna di Luciano nel Quattrocento e ai rapporti tra l’Umanesimo italiano e l'Umanesimo del Nord Europa, con una particolare attenzione al ruolo di Erasmo da Rotterdam.
Lorenzo Geri teaches Italian Literature at Sapienza University. His research interests include Petrarca, Boccaccio, Alberti, Pontano, Marino and Italian Theatre Literature of XVI and XVII century. His current research is devoted to the codification of lyric poetry in Italy from the Middle Ages to Renaissance; Petrarch and religious culture; Petrarch and Italian Courts.
Address: Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali - Università di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, Roma 00185
lorenzo.geri@uniroma1.it
less
Related Authors
Elisa Brilli
University of Toronto
Christine Gadrat-Ouerfelli
Aix-Marseille University
Charles Leavitt
University of Notre Dame
Paolo Zublena
Università degli Studi di Genova
Armando Marques-Guedes
UNL - New University of Lisbon
Giulia Sissa
Ucla
Florin Curta
University of Florida
Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Michaela Valente
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
Roland Béhar
École Normale Supérieure
InterestsView All (15)




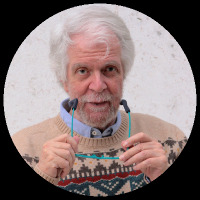





Uploads
Monografie by Lorenzo Geri
*
To the readers of the “Canzoniere” Petrarch appears to be the solitary poet par eccellence, deeply fond of his otium in the countryside. Among his wide literary production, anyway, it is possible to find many details concerning his life as a courtesan, as an influential clericus protected by Italian signori and as an expert diplomat. Such a portrait of Petrarch, blurred as it is, is nonetheless fascinating. The so called father of the Humanism attended several courts since his youth and spent most of his life under the protection of cardinals and signori whilst gathering admirers and followers (jurists, condottieri, noblemen, cardinals). Petrarch reinforced his network through occasional literary texts and the dedication of works as the “Africa” and “De viris illustribus”. His ability to exercise an influence at many relevant courts of his time (Avignon, Naples, Prague, Padua) contributed to the charm of his figure among the contemporaries. The experience as an expert of illustrious men (observator illustrium) contributed to his political letters on the education of a king, the ideal condottiero, the relationship among the signori and the littere, the perfect prince. These letters contribute to a fragmentary yet relevant and seminal ethical and political thought which would eventually influence the culture of Ancient Régime. Through the analysis of such a wide corpus, the book outlines the portrait of Petrarch as a courtesan.
ENGLISH The book studies how three great writers, belonging to different moments in the history of humanism, have assimilated the works of Lucian and used them in their works. The book, after a preliminary survey on the characteristics of the corpus lucianeo and a brief discussion on the receipt of Luciano among the humanists, is divided into three chapters devoted to Leon Battista Alberti, Giovanni Pontano and Erasmus of Rotterdam. The analysis of the presence of Lucian is conducted through a reconstruction of the context in which lucianic theme or allusion occurs, with the intent to outline the different waw in which each author rewrites Luciano .
ENGLISH The book examines the development of the theme of writing in all Petrarca’s works, in prose and in verse alike. After a preliminary study of the occurrences of the theme in Latin and Medieval authors, the book analyses the different symbolic values that are assigned to theme of writing in Petrarca’s works: the emphasis on writing instruments in polemic proses; the anxiety connected with philology; the perturbing connection between writing and alienation and between writing and death."
"
Saggi by Lorenzo Geri
The essay analyses the relationship between Francesco Petrarca and the Carthusians in the context of the growing success of the Order in the Avignon Curia. At the same time, the letters addressed to the Carthusians gathered in the Familiares and the Seniles are examined as part of a broader communicative strategy addressed by Petrarch to his high prelate protectors (Philippe de Cabassole, Henrie de Tallyerand, Gui de Boulogne) and to Urban V himself. Indeed, to these influent members of the Curia, all in varying degrees close to the Carthusian Order, Petrarch offers the model of a life that combines the exercise of the social duties proper to a high prelate with the continuous refuge in an "inner hermitage" (Fam. XIV 1, 38-39). In such an “inner hermitage”, inspired by the holy life of monks such as the Carthusians, the high prelates as well as the humanist, are supposed to both practise an otium literatum and their personal devotion.
This study examines the attitude towards poverty and wealth in Petrarch’s letters, mainly those addressed to members of the Papal Curia. The first part of the essay analyses how Petrarch in his letters, both published and unpublished, indirectly describes his condition of a wealthy member of the clergy and, at the same time, professes the ideal of an honesta paupertas (“an honest poverty”). Such an ideal is, in fact, opposed to the that of the paupertas Christi professed by the spiritual Franciscans. The second part of the essay examines how Petrarch, especially during the papacy of Urbanus V, tries to keep a channel of communication with the French cardinals, hoping to exert an influence on the Curia for the sake of the return of the Papal siege to Rome. After having discussed such a political goal, the last part of the essay examines two letters in particular: Fam. XIV 2 (to the Cardinal Elie de Talleyrand) and Sen. II 2 (to the Papal Secretary Francesco Bruni). Both the letters criticize idea that a good man of the Church should lead a life based on an ideal of strict poverty, on the basis of Seneca’s argumentations in the De vita beata and the example of Saint Ambrose.
Il saggio indaga le ragioni dalla retrotraduzione – dal volgare al
latino – della novella di Griselda, inviata da Petrarca a Boccaccio stesso, facendo luce in particolare sull’idea petrarchesca di pubblico, latino e volgare, che sta a monte di tale esperimento. Alla base c’è una lettura del Decameron che tende a valorizzare i passi stilisticamente elevati, tra i quali in particolare la novella che chiude la raccolta, e che viene dunque riproposta in latino da Petrarca con lo scopo di evidenziarne la natura esemplare, mutando però i destinatari: non più le donne e un pubblico incolto, bensì gli uomini e i dotti.
ENGLISH
This essay investigates the reasons behind the retranslation – from the vernacular into Latin – of the novella Griselda, sent from Petrarch to Boccaccio himself, with particular focus on the Petrarchan concept of readership, vernacular and Latin, which forms the background for this experiment. This study is based on a reading of the Decameron and its stylistic features, mainly the novel as the closing point of the collection, adopted by Petrarch in Latin with the aim of illustrating its exemplary nature. However, he chooses to alter his intended audience, which is now no longer composed of women and uneducated people, but rather of men and scholars.
This essay focuses on how Petrarch adopted a prophetic voice in his political writings concerning the Cu-ria. In his sonnets and prose letters he refuses an actual prophetic approach , like that of Dante, whilst imitating elements of contemporary eschatology in order to fascinate the members of the Curia. In the first part of the essay, I discuss the historical context in which the so called "Babylonian" sonnets (Rvf 136-138) were presumably written and I compare them to the prophetic writings of John of Rupescissa, well known at the time. In the second part of the essay, I compare Cola di Rien-zo's messianic propaganda with Petrarch's use of prophetic elements in order to show the difference between the two. Finally, I discuss the lorenzo.geri@uniroma1.it, Sapienza, Università di Roma.
***
Il saggio prende in esame l'influenza del secolare dibattito filosofico e teologico sul libero arbitrio nell'opera di Petrarca. Dopo un'ampia ricognizione nei codici patristici e biblici della biblioteca petrarchesca, il saggio discute l'ideale di teologia promossa da Petrarca nel suo epistolario e nel De ignorantia per poi analizzare il trattamento del tema del libero arbitrio tra Secretum e Canzoniere.
*
To the readers of the “Canzoniere” Petrarch appears to be the solitary poet par eccellence, deeply fond of his otium in the countryside. Among his wide literary production, anyway, it is possible to find many details concerning his life as a courtesan, as an influential clericus protected by Italian signori and as an expert diplomat. Such a portrait of Petrarch, blurred as it is, is nonetheless fascinating. The so called father of the Humanism attended several courts since his youth and spent most of his life under the protection of cardinals and signori whilst gathering admirers and followers (jurists, condottieri, noblemen, cardinals). Petrarch reinforced his network through occasional literary texts and the dedication of works as the “Africa” and “De viris illustribus”. His ability to exercise an influence at many relevant courts of his time (Avignon, Naples, Prague, Padua) contributed to the charm of his figure among the contemporaries. The experience as an expert of illustrious men (observator illustrium) contributed to his political letters on the education of a king, the ideal condottiero, the relationship among the signori and the littere, the perfect prince. These letters contribute to a fragmentary yet relevant and seminal ethical and political thought which would eventually influence the culture of Ancient Régime. Through the analysis of such a wide corpus, the book outlines the portrait of Petrarch as a courtesan.
ENGLISH The book studies how three great writers, belonging to different moments in the history of humanism, have assimilated the works of Lucian and used them in their works. The book, after a preliminary survey on the characteristics of the corpus lucianeo and a brief discussion on the receipt of Luciano among the humanists, is divided into three chapters devoted to Leon Battista Alberti, Giovanni Pontano and Erasmus of Rotterdam. The analysis of the presence of Lucian is conducted through a reconstruction of the context in which lucianic theme or allusion occurs, with the intent to outline the different waw in which each author rewrites Luciano .
ENGLISH The book examines the development of the theme of writing in all Petrarca’s works, in prose and in verse alike. After a preliminary study of the occurrences of the theme in Latin and Medieval authors, the book analyses the different symbolic values that are assigned to theme of writing in Petrarca’s works: the emphasis on writing instruments in polemic proses; the anxiety connected with philology; the perturbing connection between writing and alienation and between writing and death."
"
The essay analyses the relationship between Francesco Petrarca and the Carthusians in the context of the growing success of the Order in the Avignon Curia. At the same time, the letters addressed to the Carthusians gathered in the Familiares and the Seniles are examined as part of a broader communicative strategy addressed by Petrarch to his high prelate protectors (Philippe de Cabassole, Henrie de Tallyerand, Gui de Boulogne) and to Urban V himself. Indeed, to these influent members of the Curia, all in varying degrees close to the Carthusian Order, Petrarch offers the model of a life that combines the exercise of the social duties proper to a high prelate with the continuous refuge in an "inner hermitage" (Fam. XIV 1, 38-39). In such an “inner hermitage”, inspired by the holy life of monks such as the Carthusians, the high prelates as well as the humanist, are supposed to both practise an otium literatum and their personal devotion.
This study examines the attitude towards poverty and wealth in Petrarch’s letters, mainly those addressed to members of the Papal Curia. The first part of the essay analyses how Petrarch in his letters, both published and unpublished, indirectly describes his condition of a wealthy member of the clergy and, at the same time, professes the ideal of an honesta paupertas (“an honest poverty”). Such an ideal is, in fact, opposed to the that of the paupertas Christi professed by the spiritual Franciscans. The second part of the essay examines how Petrarch, especially during the papacy of Urbanus V, tries to keep a channel of communication with the French cardinals, hoping to exert an influence on the Curia for the sake of the return of the Papal siege to Rome. After having discussed such a political goal, the last part of the essay examines two letters in particular: Fam. XIV 2 (to the Cardinal Elie de Talleyrand) and Sen. II 2 (to the Papal Secretary Francesco Bruni). Both the letters criticize idea that a good man of the Church should lead a life based on an ideal of strict poverty, on the basis of Seneca’s argumentations in the De vita beata and the example of Saint Ambrose.
Il saggio indaga le ragioni dalla retrotraduzione – dal volgare al
latino – della novella di Griselda, inviata da Petrarca a Boccaccio stesso, facendo luce in particolare sull’idea petrarchesca di pubblico, latino e volgare, che sta a monte di tale esperimento. Alla base c’è una lettura del Decameron che tende a valorizzare i passi stilisticamente elevati, tra i quali in particolare la novella che chiude la raccolta, e che viene dunque riproposta in latino da Petrarca con lo scopo di evidenziarne la natura esemplare, mutando però i destinatari: non più le donne e un pubblico incolto, bensì gli uomini e i dotti.
ENGLISH
This essay investigates the reasons behind the retranslation – from the vernacular into Latin – of the novella Griselda, sent from Petrarch to Boccaccio himself, with particular focus on the Petrarchan concept of readership, vernacular and Latin, which forms the background for this experiment. This study is based on a reading of the Decameron and its stylistic features, mainly the novel as the closing point of the collection, adopted by Petrarch in Latin with the aim of illustrating its exemplary nature. However, he chooses to alter his intended audience, which is now no longer composed of women and uneducated people, but rather of men and scholars.
This essay focuses on how Petrarch adopted a prophetic voice in his political writings concerning the Cu-ria. In his sonnets and prose letters he refuses an actual prophetic approach , like that of Dante, whilst imitating elements of contemporary eschatology in order to fascinate the members of the Curia. In the first part of the essay, I discuss the historical context in which the so called "Babylonian" sonnets (Rvf 136-138) were presumably written and I compare them to the prophetic writings of John of Rupescissa, well known at the time. In the second part of the essay, I compare Cola di Rien-zo's messianic propaganda with Petrarch's use of prophetic elements in order to show the difference between the two. Finally, I discuss the lorenzo.geri@uniroma1.it, Sapienza, Università di Roma.
***
Il saggio prende in esame l'influenza del secolare dibattito filosofico e teologico sul libero arbitrio nell'opera di Petrarca. Dopo un'ampia ricognizione nei codici patristici e biblici della biblioteca petrarchesca, il saggio discute l'ideale di teologia promossa da Petrarca nel suo epistolario e nel De ignorantia per poi analizzare il trattamento del tema del libero arbitrio tra Secretum e Canzoniere.
This essay provides a critical analysis of Coluccio Salutati’s "De seculo et religione" in order to make a comparison between Salutati’s religious writings and Petrarch’s works written in a «monastic style» (i.e. "De vita solitaria", "De otio religioso", Sen. X and the letters to Gherardo). After an overview of the critical reception of "De seculo et religione", the essay examines sources, structure and style of the treatise and studies Salutati’s relationship with contemporary preaching through the analysis of the chapter «Quod mundus est temptationum palestra». Finally, the essay discusses the possibility that Petrarch’s religious writings could be a relevant source for the “De seculo et religione”.
The essay focuses on the first two travel books written by Fosco Maraini (1912-2004), a relevant Italian photographer, mountaineer, anthropologist and academic. Such an analysis shows how Maraini eventually created his unique style and invented a peculiar form of travel book which mixes different elements: travel impressions, the description of shrines and artifacts, the evocation of charming characters, both Tibetans and members of the expedition, considerations on cultural exchanges and reciprocal influences between East and West.
Il saggio prende in esame il ruolo della preghiera nei Rerum vulgarium fragmenta con l’intento di ricostruire il percorso che collega idealmente incipit ed explicit, dall’innamoramento durante il venerdì santo alla canzone Vergine bella, tra la prima parte dedicata al «giovanile errore» e la seconda dedicata alla maturità, la vecchiaia, la preparazione alla morte. Dopo una discussione preliminare in merito al ruolo della preghiera nell’ideale petrarchesco di un otium senile improntato alla literata devotio, si analizzano le orationes in versi (Rvf 62; 80, vv. 37-9; 214, vv. 25-36; 364-6), mettendo in evidenza il maturare, redazione dopo redazione, del tema della preghiera in punto di morte, tema strettamente intrecciato col finale del libro.
ENGLISH
The essay focuses on the prayers included in Rerum vulgarium fragmenta in order to show how praying characterizes the development of Petrarch’s self-portrait from the first part of the book devoted to the «giovanile errore» to the second part devoted to maturity and old age. After a preliminary discussion of Petrarch’s ideal of pious old age, the essay analyses all the prayers included in the book (Rvf 62; 80, vv. 37-9; 214, vv. 25-36; 364-6), showing the development, forms after forms, of the theme of preparation for death.
ENGLISH
The essay is devoted to the allegories of Divine Providence in Italian pastoral dramas from 1544 (Andrea Beccari’s “Il Sacrificio”) to 1607 (Guidubaldo Bonarelli “Filli di Sciro”). The focus is mainly on the analysis of “Il Pastor fido”, a well known turning point in the history of European Pastoral Drama, and “La Filli di Sciro”, a drama in which the influence of Tasso and Guarini is combined with a baroque style. In the “Pastor fido” the story represented in the drama is shown to spectators not as the result of a blind chance but as the providential effect of a Celestial Will. At the same the happy ending regards not only two families but a whole community redeem from an ancient crime by a providential marriage. Such a new interpretation of the pastoral Drama is shared by Bonarelli: the love between Clori and Nis has a redemptive effect on the isle of Sciro, freed from the invaders thanks to the wedding gift the king of Traces provides to the two youngers. In both “Pastor Fido” and “Filli di Sciro” the happy ending, which none of the characters of the play is able to foresee, is considered to be a demonstration and, at the same time an allegory, of the inscrutability of the decrees of Providence. Such an allegorical approach to the pastoral drama is widely common in Renaissance and Baroque Europe. For instance, in 1647 George Talbott, dedicates his manuscript translation of “Filli di Sciro” to Carl II as an allegory of the isle of England, soon to be providentially freed from Cromwell.
Arezzo, Accademia Petrarca di Scienze, Lettere e Arti, 10-11 aprile 2025
Il mio intento è quello di procedere a una lettura in parallelo della recusatio che apre l’Africa e l’apostrofe a Roberto e ai posteri che la chiude, allo scopo di inquadrare la stesura provvisoria del poema messa insieme durante il secondo soggiorno parmense (1344-1345) nell’ambito di una strategia comunicativa più ampia, volta a rilanciare il modello del mecenatismo augusteo. Siffatta strategia, pur prendendo le mosse dal macrotesto dedicato all’incoronazione, non è indirizzata alla corte napoletana (segnata, dopo la dipartita del sovrano, dall’instabilità politica e da un destino incerto) ma ai signori dell’Italia settentrionale, con uno sguardo rivolto sia ai domini del suo tempo a partire da Giovanni Visconti, con il quale proprio le vicende parmensi lo misero in contatto – quanto a quelli del futuro. Il ruolo che, in tale progetto, avrebbe potuto svolgere l’Africa, alla cui pubblicazione Petrarca continua a lavorare sino agli anni Sessanta, può essere ricostruito per via indiziaria prendendo in esame i testi relativi al soggiorno milanese, con la definizione del mecenatismo visconteo in contrapposizione agli strali polemici di Boccaccio e dei sodali fiorentini, e le successive lettere-trattato indirizzate ai domini, sino alla Sen. XIV 1 e al programma iconografico ideato per la Sala degli Eroi a Padova.
Per quanto il giudizio erasmiano nei confronti di Petrarca sia notoriamente sprezzante allo scopo di ridimensionare il ruolo della prima generazione degli umanisti italiani nella Rinascita delle litterae, l’influenza dell’opera petrarchesca su quella erasmiana merita un’indagine ravvicinata (vd RICO 2008). La fioca stellula di Petrarca che per primo iniziò a diradare le tenebrae medievali (la definizione è adottata da Vives nel suo catalogo degli autori eminenti del genere epistolare, vd Vives 1989 ll. 1106-1112) dovette, se non abbagliare Erasmo, perlomeno giungergli con sufficiente nitore. La produzione epistolare petrarchesca, infatti, rubricata da Brandt come Opus epistolarum, il medesimo titolo che Erasmo avrebbe scelto per la più importante delle sue raccolte (Basilea, Froben, 1529), rappresentò per l’ambizioso umanista di Rotterdam un corpus con il quale misurarsi in un certamen dissimulato, complementare nei confronti di quello esplicitamente rivendicato nei confronti di Ermolao Barbaro e Angelo Poliziano (vd ad es. Allen XI, n. 3032, a John Choler, <Agosto> 1535).
Tra le spie di tale corpo a corpo si discuterà la prefazione delle Epistolae ad diversos nella quale si trova una significativa allusione alla prima lettera del primo libro delle Familiares (si legge, scorporata dalle altre lettere, in PETRARCA 1496: 541-546 col titolo di Epistolaris praefatio). Nella sua dedicatoria a Beato Renano, infatti, Erasmo racconta di aver ricevuto da un amico un manoscritto contenente alcune sue lettere inedite acquistato presso un librario di Siena. Sorpreso dal rileggere missive che credeva perdute, avrebbe deciso di bruciarle tutte, pur essendo, alcune di esse, degne di essere conservate; tale gesto, però, sarebbe stato a sua volta vanificato dalla presenza di innumerevoli altri manoscritti contenenti quelle medesime lettere:
Nam Senae cum essem, humanissimus ille Piso, qui tum Regis sui nomine oratorem agebat apud Iulium Pontificem, repperit apud bibliopolam quendam prostantem codicem epistolarum Erasmi, sed manu descriptum: emi tac mihi misit. In hoc tametsi erant multa quae fortasse non indigna videri poterat quae ervarentur, tamen offensus casu tam inopinato, totum quantus erat, Vulcano dicavi. Reuersus repperi hic similes libellos apud complures adseruari, in aliquot exemplaria transfusos (Allen IV, p. 499, ll. 19-33).
Il sintagma Vulcano dicavi (che non viene registrato negli Adagia) allude proprio alla lettera proemiale delle Familiares:
Quid multa? incredibilem forte rem audies, veram tamen, mille, vel eo amplius, seu omnis generis sparsa poemata seu familiares epistolas, non quia nichil in eis placuisset, sed quia plus negotii quam voluptatis inerat, Vulcano corrigendas tradidi (PETRARCA 1496: 542C)
L’allusione ha lo scopo di evocare il contrasto tra le poche missive serbate dal caso nella biblioteca di Petrarca e la lotta impari di Erasmo nei confronti di una diffusione incontrollata delle proprie lettere, a stampa e manoscritte, un fenomeno a cui allude lo stesso paratesto dalla raccolta messa insieme dai curatori degli Opera omnia: Opus epistolarum complectens universas quotquot ipse autor unquam evulgavit aut evulgatas nolui.
Il gesto di rileggere le lettere di una vita con l’intento di guardarsi indietro (Fam. I 1, 4) viene rievocato da Erasmo nella prefazione all’ultima raccolta delle sue missive del 1536. La necessità di scegliere tra le sue carte un gruppo di lettere inedite per contrastare quanti pubblicavano senza autorizzazione ogni tipo di frammento letterario a lui attribuibile, costringe l’umanista ad un forzato memento mori, simile a quello che caratterizza la prima delle Familiares:
Inter excutiendum schedas illud admonuit me conditionis humane, quod inter tam multas epistolas plerasque intra decennium scriptas, tam paucae venirent ad manus quarum autores essent superstites. Homo bulla (Allen XI, Ep. 3100, p. 290, ll. 84-87)
Se la presenza della memoria della lettera petrarchesca a Socrate caratterizza due importanti prefazioni erasmiane, la stessa scelta di ordinare la raccolta più ampia delle proprie missive (1025 pezzi) in ventiquattro libri (il già menzionato Opus epistolarum del 1529) sembra configurarsi come una sfida alle Familiares, il cui originario ordinamento, scompaginato nell’edizione di Brandt e nella stampa fiorentina del 1501, parrebbe noto all’umanista olandese. Sulla quantità e qualità di notizie relative a Petrarca note ad Erasmo, d’altronde, è necessario intraprendere uno studio che ampli quanto emerge dall’epistolario, sempre parco di notizie in merito alla lettura delle opere delle prime generazioni di umanisti. Non ci sono dubbi, ad ogni modo, che l’amicizia con non pochi «uomini eruditi» italiani dei suoi tempi che viene evocata per difendersi dalle accuse odio nei confronti dell’Italia in una lettera del 1535 (vd Allen XI, n. 3032) comportasse la discussione, tra le altre materie relative alle fabulae litteratae (Allen XI, n. 3032, l. 216-17), delle opere degli umanisti italiani, Petrarca compreso.
SIGLE
ALLEN = Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, edited by P.S. Allen et alii, Clarendon, Oxford, 1906-1958, 12 voll.
HALKINS 1983 = L. HALKINS, Erasmus ex Erasmo. Érasme éditeur de sa correspondance, Aubel, Gason
PETRARCA 1496 = Librorum Francisci Petrarchae, Basel, Johannes Amerbach [GW M31505]
RICO 2008 = F. RICO, Erasmo e Petrarca: “Nunc vix est in manibus”, in «Quaderni petrarcheschi», 17/18 (2007/2008) pp. 1015-1026
VIVES 1989 = J. L. VIVES, De conscribendis epistolis, critical edition with introduction, translation and annotation by C. Fantazzi, Brill, Leiden, 1989
Petrarca cortigiano. Francesco Petrarca e le corti da Avignone a Padova, Roma, Bulzoni Editore, 2020.
Dialogheranno con l’autore James Houston (Gonzaga University) e Gabriele Baldassari (Statale di Milano)
La lettura ravvicinata delle pagine in questione permette di affrontare, da una specola parziale ma significativa, tre aspetti del pensiero di Guicciardini: a) la riflessione sulle caratteristiche peculiari del papato (inteso come istituzione storico-politica) in rapporto alla storia di Firenze, d’Italia e d’Europa, una riflessione condotta per mezzo di un dialogo sotterraneo e postumo con Machiavelli; b) l’insegnamento che è possibile ricavare dalle vicende dei due papati medicei al fine di assolvere ai compiti che attendono i «buoni cittadini» (Ricordi, C 220) in una Firenze in cui la potestà dei Medici si fa «assoluta e quasi regia» (Storia d’Italia, XX II); c) la cauta ma acuta indagine in merito al ruolo della religione nei moti della storia, dalla forza peculiare insista nell’«autorità» dei pontefici (forza che muove le vicende diplomatico-poliche) al ruolo svolto dalle profezie e dai predicatori carismatici (Savonarola e Lutero) nella crisi dell’ordine costituito, una divisione del corpo sociale che passa attraverso il rifiuto dell’autorità della Chiesa in nome della pretesa di possedere «un’autorità divina» (Storia d’Italia, II II).
Per affrontare, almeno parzialmente, tali questioni l’intervento si articolerà in due parti. La prima parte si concentrerà sull’ultima redazione dei Ricordi, mettendo in evidenza l’importanza delle riflessioni suscitate dall’assedio di Firenze e dalla successiva resa della città, con il conseguente inizio di una rinnovata «tirannia» medicea, nella struttura stessa della raccolta. Chiarita l’importanza di tale prospettiva, si passerà ad una rassegna dei ricordi relativi rispettivamente a: i pontefici serviti da Guicciardini; la corte e i suoi meccanismi; il ruolo della religione nella storia (in rapporto con il ruolo dell’eredità di Savonarola nella resistenza di Firenze). La seconda parte si concentrerà sull’excursus del quarto libro della Storia d’Italia sulla storia del papato (censurato nelle stampe italiane ma recuperato in terra riformata) e sulla rappresentazione di Leone X nell’opera, per chiudere, infine, con l’analisi della pagina dedicata a Lutero in relazione ai ricordi ispirati al monaco tedesco (C28, B124, C125, C 159).
Nel corso del seminario si prenderanno in esame storia, caratteristiche e fonti di tre opere composte tra la fine del XIV secolo e i primi decenni del XVI: il De seculo et religione di Salutati (1381), un trattato sulla vita monastica che prende spunto tanto dai testi di argomento “monastico” di Petrarca quanto dalla predicazione coeva e si rivolge alla comunità eremitica camaldolese di Santa Maria degli Angeli a Firenze; i Sermoni evangelici composti da Sacchetti; la Esortazione alla penitenza (1525) orazione tenuta da Machiavelli a Roma, probabilmente presso la Arciconfraternita della Carità, come contributo alla politica politico-religiosa di Clemente VII al pari della coeva De immensa Dei misericordia Concio (1524) di Erasmo da Rotterdam.
Programma.
BEATRICE ALFONZETTI (direttore del Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali), Saluti
LORENZO GERI (Sapienza Università di Roma), Il De seculo et religione di Coluccio Salutati
NICOLÒ MALDINA (University of Edimburgh), I Sermoni evangelici di Franco Sacchetti
GAETANO LETTIERI (Sapienza Università di Roma), La Esortazione alla penitenza di Niccolò Machiavelli
Discutono: LUCA D’ASCIA, SONIA GENTILI, PAOLO FALZONE, MARCO GRIMALDI, GIORGIO INGLESE, AMEDEO QUONDAM, PASQUALE TERRACCIANO.
si terrà la presentazione del volume di Michele Camaioni, Il governo dei pulpiti. Predicatori, potere e pubblico nell’Italia della prima età moderna (Edizioni di Storia e Letteratura, 2024)
Interverranno, oltre all'autore:
Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma)
Lorenzo Geri (Sapienza Università di Roma)
Maria Fallica (Sapienza Università di Roma
Nel corso degli incontri tenuti periodicamente presso il Laboratorio si prenderanno in esame testi risalenti a stagioni diverse della vita e del pensiero di Erasmo, trattati, dialoghi, traduzioni, commenti, componimenti in versi, orazioni, lettere, manuali, prefazioni. A partire da tali opere lo sguardo si allargherà ai contesti interessati dalla multiforme attività dell’umanista di Rotterdam, con una particolare attenzione ai rapporti, complessi e ambivalenti, tra Erasmo e la cultura italiana.
Il Laboratorio ospiterà, pertanto, tre tipologie di incontri: le Letture erasmiane, con le quali si offrirà una lectio analitica di opere, epistolario, attività filologico-editoriale; i seminari metodologici Tradurre e commentare Erasmo, occasione di confronto tra editori, traduttori, studiosi; i Circuiti erasmiani, giornate di studio dedicate ad autori, personaggi ed opere connessi con il rapporto tra Erasmo e la cultura europea, soprattutto italiana.
Responsabili: Gaetano Lettieri (Dipartimento di Storia, Culture, Religioni)
Lorenzo Geri (Dipartimento di studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali)
CALENDARIO (FEBBRAIO-MAGGIO 2018)
Colloquia [Convivium religiosum] – Lorenzo Geri (Sapienza Università di Roma) giovedì 22 febbraio, ore 10, aula B di Storia Medievale
Prefazioni ai Padri – Maria Fallica (Sapienza Università di Roma) venerdì 16 marzo, ore 10, aula B di Storia Medievale
Iulius – Cora Presezzi (Sapienza Università di Roma) venerdì 20 aprile, ore 11, aula C di Storia Medievale
Lettere a Sadoleto – Ludovico Battista (Sapienza Università di Roma) mercoledì 23 maggio, ore 10, aula C di Storia Medievale
PROSSIMI INCONTRI
Enchiridion – Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma); Ecclesiastes – Nicolò Maldina (Università di Edimburgo); Prefazioni alle traduzioni di Luciano – Irene Fantappiè (Freie Universität, Berlin); Colloquia [Inquisitio de fide] – Andrea Annese (Sapienza Università di Roma)
Il seminario si svolge in occasione dell'uscita dei volumi: Il Dante di Petrarca. Atti del Convegno internazionale di Arezzo, 4-6 novembre 2021, a cura di Marco Capriotti, Natascia Tonelli, Alessia Valenti, Antenore, 2024 e Il Dante di Boccaccio. Atti del Convegno, Certaldo Alta, Casa di Giovanni Boccaccio (9-10 dicembre 2021), a cura di Natascia Tonelli, Olschki, 2024.
Interverranno: Lorenzo Geri (Sapienza Università di Roma) e Marco Grimaldi (Sapienza Università di Roma).
L'incontro si svolge nell'ambito delle attività del Centro Studi sulla Poesia Medievale (https://lcm.web.uniroma1.it/it/centro-studi-sulla-poesia-medievale), direzione scientifica a cura di Lorenzo Geri e Marco Grimaldi.
Gli studi raccolti, nati nell’ambito dell’omonimo gruppo di ricerca, fanno perno, da diverse prospettive metodologiche, sul concetto di libertà, che è il centro irriducibilmente problematico, persino eversivo, che segna l’approccio critico di Erasmo nei confronti del cattolicesimo romano del suo tempo, il suo scarto nei confronti di Lutero, la novità radicale della sua fede razionale.
Una inquieta e vitale libertà che, allo stesso tempo, caratterizza anche l’ambiziosa e originale aemulatio erasmiana nei confronti delle letterature classiche e dell’Umanesimo italiano.
Contributi di A. Annese, L. Battista, E. Cerqua, M. Fallica, L. Geri, V. Lauria, G. Lettieri, C. Presezzi, M. Quatrale.
***
Il volume prende in esame, con un approccio multidisciplinare, il dibattito in merito al libero arbitrio tra la fine del Medioevo e primi decenni del Cinquecento. Specialisti di storia del pensiero, storia della teologia ed italianistica conducono il lettore attraverso un gruppo ristretto ma significativo di casi di studio: dalla poesia lirica in volgare del Medioevo italiano (Sara Ferrilli) a Francesco Petrarca (Lorenzo Geri); dalla riflessione di Lorenzo Valla (Mariangela Regoliosi) alla sistemazione del dibattitto del primo Umanesimo in Giannozzo Manetti (Stefano Baldassarri); per arrivare ad Erasmo da Rotterdam (Pasquale Terracciano, Christian Houth Vrangbæk) e Martin Lutero (Anders-Christian Jacobsen). La storia secolare di uno dei nodi caratteristici del pensiero e della cultura occidentale è dunque affrontata concentrando l’attenzione nel passaggio dalla nascita dell’Umanesimo agli albori della Riforma. Seguire il dipanarsi del dibattito sul libero arbitrio permette, infatti, di affrontare da una prospettiva privilegiata sia testi notissimi, come l’erasmiano De Libero Arbitrio, che contributi meno noti ma altrettanto significativi.
I saggi raccolti nel volume offrono una ricognizione mirata, condotta per campioni e casi di studio esemplari, che prende le mosse da un quadro critico aggiornato per riflettere su alcuni problemi ancora aperti, privilegiando una prospettiva attenta alla continuità dei fenomeni di lunga durata nella storia religiosa e nella scrittura letteraria tra Medioevo e Rinascimento. L’esigenza di riconsiderare il rapporto tra lirica e sacro alla luce della specificità del genere – al cui interno agiscono le tensioni dialettiche tra sfera profana e spirituale, tra codice amoroso e Parola biblica, tra poesia e preghiera – nasce dalla volontà di rileggere in chiave problematica l’applicazione al dato letterario di categorie ermeneutiche derivanti da nozioni storiografiche quali Riforma e Concilio, coniate in relazione ai grandi rivolgimenti del pensiero religioso moderno e interpretate talvolta come spartiacque fin troppo netti nei confronti della produzione e della circolazione dei testi.
Intervengono:
J. Bartuscha, University of Zürich (Bono Giamboni e Brunetto Latini),
P. Nasti, University of Reading (Dante)
L. Geri, Università di Roma “La Sapienza” (Petrarca),
S. Carrai, Università degli Studi di Siena (Boccaccio).